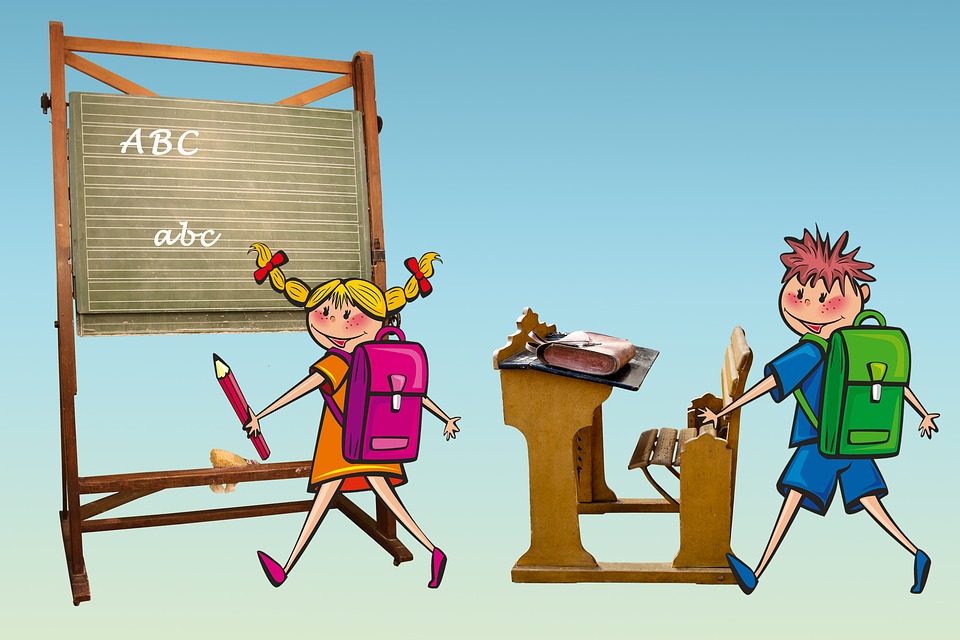Una riflessione sulla scuola italiana
Scritto da Maria
Raccontare la scuola è come raccontare il mondo: l’impressione è sempre la stessa, quella di rimanere in superficie a guardare la punta di un iceberg, senza la consapevolezza di quello che si agita o si potrebbe esplorare nei fondali. E il primo errore di valutazione, forse, lo abbiamo già fatto dalla prima riga. Aggiustiamo allora il tiro: la scuola non è come il mondo. La scuola è il mondo, quello dell’oggi, ma soprattutto quello del domani. Ci racconta che cosa siamo e che cosa saremo o avremo deciso di essere. Sono anni che l’informazione poco si occupa di questa istituzione e che, quando lo fa, si concentra, esclusivamente e per puro dovere di cronaca, a parlare di quello che “ha” non di quello che “è”, ammesso che la scuola “sia” ancora qualcosa. E la gente registra certe notizie senza ascoltarle, senza più dare loro un valore, per cui in merito all’argomento son decenni che circolano sempre le stesse opinioni: insegnanti fannulloni e incapaci o, nel migliore e più compatito dei casi, precari, alunni perditempo o bulli, strutture fatiscenti.
“Vecchia” è il solo aggettivo associato alla scuola che però la rappresenti autenticamente, al di là di ogni strumentalizzazione e del pessimismo più nero. La scuola è vecchia, ma non nel senso che vi aspettereste. Non per la classe docente che ormai supera in media i sessant’anni o per gli edifici malridotti. Non è questo il motivo che la rende decrepita. Anche se è quello che vogliono farci credere. Se ciò fosse vero, allora per rinverdirla basterebbe un colpo di spugna, basterebbe davvero inventarsi, come è stato fatto negli ultimi mesi, registri e libri di testo in formato elettronico o iscrizioni on line. Ma non è così.
Si invecchia quando si smette di sperare. E la scuola italiana ha smesso di farlo. Demagogicamente e populisticamente sarebbe semplice riempire questo articolo di tutti quelli che sono i suoi problemi. Si potrebbe cominciare dalla mancanza di carta igienica, di gesso per le lavagne, di inchiostro e carta per stampanti e fotocopie, di combustibile per i riscaldamenti, di pc per insegnati e alunni, fatto quest’ultimo che la dice lunga sulla scuola del futuro, quella giovane, quella dove basta un click. Si potrebbe parlare di scuole “arrangiate” in edifici che erano palazzi privati, dove gli alunni, mai meno di venti per classe, vengono stipati in cucine e bagni oppure di strutture non più sicure e che andrebbero ristrutturate. Ma nemmeno tutte queste costatazioni sarebbero capaci di rendere vecchia la scuola. Le mancanze economiche e strutturali danneggiano la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, ma di per sé non sono responsabili del fatto che oggi la scuola appaia come un’anziana signora. La sua età non è data da un fattore esterno, per cui, sì, ci auguriamo che si possano trovare fondi da destinare a questa istituzione per sanare le sue carenze e che l’avvento di strumenti elettronici possa ottimizzare la formazione dei ragazzi – e per far ciò andrebbe completamente riprogrammata la didattica e riformulati i libri di testo, perché la probabilità più alta è che la scuola telematica del futuro sia una brutta figlia di quella attuale, nata da una semplice triturazione di programmi e contenuti, il cui fine consiste solo nella lotta alla sopravvivenza per le case editrici, piuttosto che in un investimento di energie per concepire nuove possibilità di studio – ma non riteniamo che la questione si risolva in questo modo.
Bisogna andare a fondo e nel fondo della scuola, alle sue basi, dentro e fuori di essa, c’è un sostrato umano tutto da analizzare. È l’umano che andrebbe esplorato, alla ricerca di questa vecchiaia che sta cambiando la scuola. E le tipologie umane che la popolano sono almeno tre: quelli che comandano, quelli che brigano, quelli che subiscono. Scontato? Forse che sì, forse che no vi risponderebbe, se potesse parlare, D’Annunzio.
Al primo gruppo appartengono sia i dirigenti e sia i genitori – gli uni alla ricerca di iscritti, perché, per chi non lo sapesse, oramai la scuola deve vendere se stessa e la cosa non sarebbe tanto deplorevole, se a essere in vendita fosse la conoscenza, gli altri sempre pronti a insegnare ai docenti parassiti il loro lavoro. Entrambi hanno smarrito quel sentimento che dove si fa formazione, alla vita e alla professione, non dovrebbe andare mai perso: la fiducia, nelle persone che insegnano e nelle materie che si insegnano.
Al secondo gruppo appartengono gli insegnati, quelli “over sessanta” e “over venticinque”. I primi costituiscono l’80% della classe insegnate e per lo più sono stanchi del loro lavoro, sono delusi da una professione che non sentono più appartenere loro e che continuano a fare perché qualcuno ha allungato l’età pensionabile. Del resto non potrebbe essere diverso. Loro hanno vissuto la scuola quando questa ancora faceva sognare, quando ancora era un valore. I secondi, una percentuale minima, vivono la scuola come un miraggio. Pagati sempre in ritardo, continuamente peregrini da un istituto all’altro, la loro attività di insegnamento è sempre una meteora, luminosa, affascinate, ma destinata a durare poco. Eppure loro ci credono, sono gli unici che ci credono ancora. Hanno sfidato il ludibrio familiare e pubblico quando hanno scelto questo mestiere e se lo hanno fatto, a differenza di quanto avveniva per il passato, lo hanno fatto solo per passione, solo per seguire una visione, quella dell’eternità delle emozioni che si trasmettono e di quelle che si ricevono dagli allievi. Eh, sì, perché la scuola prima d’insegnare dovrebbe emozionare. Che ne sarebbe di Dante, Shakespeare, Leopardi, senza emozioni? Ma che ne sarebbe anche delle conoscenze matematiche, fisiche, chimiche se perdessimo di vista l’entusiasmo di Galileo quando parla del mondo come di un libro da imparare a leggere, perché Dio ha dato solo all’uomo questa possibilità? Nulla, non ne sarebbe nulla. Esattamente quello che accade oggi. Perché?
Per rispondere veniamo all’ultima tipologia umana che si rintraccia nel grande zoo scolastico, gli studenti: quelli che subiscono le aspettative dei genitori, a cui fino a qualche tempo fa interessava la felicità e la maturazione dei figli, prima che esse venissero identificate con un conto in banca, che subiscono le frustrazioni dei docenti, quelli che non ne possono più e quelli appena lattanti che inorridiscono dinanzi all’apatia di questi ragazzi che spegne i loro furori, quelli che subiscono le ansie della società che li partorisce. Gli studenti. È in loro che si concretizza lo spettro del vecchio. Se ai trentenni di oggi i ritmi e le esigenze della nostra società hanno ucciso i sogni, agli studenti la precarietà della vita e l’indeterminatezza del futuro li ha negati completamente.
E una società che nega i sogni nega il futuro.
Una scuola che nega la speranza è una scuola vecchia.
Per cui eccoli qui i ragazzi della scuola, nella scuola: spigliati fino al disprezzo delle regole e fragili nei loro sogni di carta, nella loro disillusione che diventa angoscia esistenziale. E come dare loro torto? Sedere tra i banchi è solo aspettare un diploma che li renderà disoccupati, in una società che non sa riprogrammarsi e che non ha insegnato loro né la gioia del sogno né la fatica del reinventarsi.
Il loro disincanto, oggi, è la colpa peggiore.
Sbaglierebbero quanti tendessero a fare di questo discorso un ragionamento di stampo morale, perché una scuola vecchia, vecchia nei giovani che dovrebbero pensare propositivamente al futuro, è un problema ben più che etico, è un problema economico. Una scuola vecchia non è forse il frutto di una società che ha smesso di investire, di credere nello sviluppo, di credere in una possibilità, di una società che parcheggia le leve del futuro in un asilo di falsi bisogni e di vuote ambizioni?
Per tutto l’articolo clicca qui